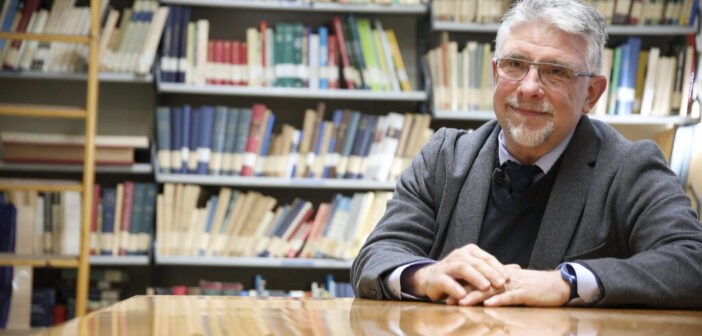“Le medie aziende agricole, per fare un esempio quelle nell’ordine dei 50-100 ettari a indirizzo orticolo o un’azienda cerealicola sopra i 300 ettari sono disposte a investire in trattori e macchinari, ma altrettanto devono investire in capitale umano. Bisogna investire in formazione e tali imprese agricole devono pianificare un investimento di uno stipendio annuo per la digitalizzazione, altrimenti è inutile investire”. È l’invito del professor Marco Vieri, ordinario di Meccanica Agraria all’Università di Firenze, che, intervistato da Veronafiere, ha tracciato il quadro dell’agricoltura di precisione in occasione di Fieragricola Tech, evento dedicato alle tecnologie, alla digitalizzazione, energie rinnovabili, smart irrigation, biostimolanti che si è svolto l’1 e 2 febbraio nella città scaligera.
Professor Vieri, a che punto è la ricerca in agricoltura di precisione? Quanto è diffusa l’agricoltura di precisione in Italia e come si colloca l’Italia?
“Mi permetto di iniziare con una premessa, un documento del 2016 che è una pietra miliare sull’agricoltura di precisione in Europa, prevedeva che sarebbe cresciuta del 12% ogni anno. Di fatto, a seconda delle zone, in Italia la media dell’adozione dell’agricoltura di precisione è tra l’1% e il 3 per cento. Di più: oggi siamo nel 32° anno dal lancio dell’agricoltura di precisione, presentata nel 1991 dal professor John Schueller dell’Università della Florida, al quale ha fatto seguito nel 1997 a Warwick, nel Regno Unito, il primo congresso europeo sull’agricoltura di precisione promosso dalle associazioni di ingegneria agricola EurAgEng e Cigr. Mi verrebbe da dire che qualcosa è andato storto.
In Italia convivono due situazioni contrapposte: da un lato abbiamo grandi aziende o grandi contoterzisti che adottano l’agricoltura di precisione, ma paradossalmente non sempre riescono a venderla ai committenti, che inspiegabilmente talvolta non sono interessati, mentre dall’altro lato ci troviamo di fronte a una galassia di piccole e medie aziende dove l’agricoltura di precisione direi che resta al di sotto del 2 per cento”.
A livello europeo, come si colloca l’Italia?
“L’Italia si colloca nelle posizioni più basse, a parimerito con la Grecia. La Spagna è molto più avanti di noi e molto più avanti sono tutte le altre Nazioni. Bisogna a che dire che fanno la differenza l’uniformità delle filiere e delle condizioni colturali e, in genere, le dimensioni aziendali, che sono più grandi di quelle italiane”.

Quali sono gli ostacoli alla diffusione dell’agricoltura di precisione?
“Innanzitutto c’è un problema di percezione: la mia generazione, quella che ha all’incirca 60 anni, non capisce il valore dell’agricoltura di precisione. Allo stesso tempo, scontiamo un problema di digitalizzazione delle infrastrutture e un problema di formazione. Anche a livello universitario dobbiamo modificare l’approccio. Come Università di Firenze stiamo collaborando con la Regione Toscana, che sta lanciando misure legate all’innovazione all’interno del Programma di sviluppo rurale, stiamo formando gli agronomi con specifici corsi e stiamo modificando il nostro approccio all’interno dell’Università, dove stiamo collaborando con nuove figure professionali. Dialoghiamo con ingegneri meccanici, ingegneri gestionali, ingegneri informatici, perché oggi è molto più importante conoscere i sistemi Gis e di digitalizzazione, dove vanno i dati e chi li controlla, anziché come si costruisce un motore”.
Di chi è la proprietà dei dati?
“Sono appetiti da tutti coloro che sono al di fuori del settore agricolo, mentre non sempre il comparto agricolo si rende conto della loro importanza. Come Università di Firenze abbiamo lavorato a un progetto per realizzare una piattaforma digitale per la viticoltura e olivicoltura nel comprensorio di Montalcino. Ebbene, gli agricoltori erano ben contenti di condividere i dati dalle centraline meteorologiche, perché questo consentiva di avere delle previsioni molto più puntuali non solo per chi non aveva le centraline, ma anche per chi le aveva. Però gli stessi agricoltori hanno mostrato resistenze sulla condivisione dei terreni e delle varietà coltivate, custodite gelosamente perché considerate parte del know how essenziale per produrre i vini. Per cui, da un lato la piattaforma raccoglieva tutti i dati, dall’altro, sulla base di accordi di riservatezza, solo una parte veniva resa pubblica.
Riscontriamo invece molto interesse da parte delle agenzie regionali, che tentano di dare un ordine ai dati e che li potrebbero utilizzare anche in funzione dei controlli o dell’erogazione dei fondi.
Vengo alla questione che mi ha posto: di chi sono i dati? Questo è un problema legislativo, così come di pari importanza è capire qual è la corretta risoluzione dei dati. Come si gestisce una mole immensa di dati? Con quali criteri? Anche la realizzazione di mappe di prescrizione richiede impegno e deve essere fatta con parametri dimensionali corretti, altrimenti rischio di avere pixel di un metro e le macchine operatrici impazziscono. I dati devono essere tarati in modo utile. E anche la scelta delle tecnologie deve essere individuata con attenzione. I droni, ad esempio, sono molto utili per raccogliere informazioni, ma bisogna anche dire che poi servono 20 o 30 ore di lavoro per elaborare un dato di 5 centimetri: va bene per la ricerca, non per il privato”.
Come è possibile favorire la condivisione dei dati?
“I dati devono essere scomposti. Noi ci occupiamo di dati per la gestione delle colture di pieno campo, e per la gestione colturale, al pari di un calendario di lavoro. Dobbiamo arrivare a una migliore gestione in ogni zona dell’appezzamento e serve un sistema di supporto alle decisioni aziendali, molto snello, ma che tramite una check-list regoli ogni aspetto, dalla gestione del trattore e degli attrezzi fino al recupero dei dati, al ricovero del parco mezzi, ai sistemi di supporto alla decisione”.
In futuro avremo imprese agricole iper-specializzate, gestite da imprenditori con poca o pochissima manodopera o avremo diversi modelli frastagliati e molto diversi fra loro, ma tutti economicamente sostenibili?
“Parto dall’ambito rurale e urbano, per dire che la digitalizzazione, la di comunicazione internet, IoT e le aziende di servizi possono annoverare figure che si collocano in ambito urbano, in quanto i sistemi digitali accorciano le distanze tra mondo rurale e mondo urbano”.
Come sarà l’agricoltura 2040?
“Il ricambio generazionale sarà avvenuto e la digitalizzazione sarà entrata. Un discorso diverso merita la robotizzazione, importantissima quando ci sono compiti ripetitivi, come gestire il sotto-fila di una vigna e tutte quelle operazioni che richiedono lo svolgimento di un lavoro con continuità e senza vincoli di luce e di orario. Parliamo ad esempio dei robot di mungitura o per la distribuzione automatizzata dell’alimentazione, soluzioni che si diffonderanno, perché in tal caso la macchina lavora meglio dell’uomo.
Nel pieno campo le condizioni sono diverse rispetto alle aree protette, come una serra o una stalla, e il grado di variabilità nella gestione è enorme, per cui ritengo difficile arrivare ad un’agricoltura in assenza completa dell’uomo. Potremmo però avere un operatore che a distanza gestisce e monitora più robot in lavorazione in un’azienda o in un comprensorio di aziende e, terminato il lavoro, passa in un’altra area agricola.
Per viticoltura e frutticoltura, invece, sarà più facile adottare sistemi digitalizzati come l’irrorazione a rateo variabile, e questo per gli obblighi di riduzione o abbattimento di alcune sostanze attive o formulati già entro il 2030. Le aziende agricole che non investiranno dovranno rivolgersi ai contoterzisti, ma al di là dei vincoli legislativi che impongono determinate scelte, è logico che i prodotti che non sono commodity come il vino non possono non tenere conto dell’immagine che assicurano i parametri di sostenibilità”.