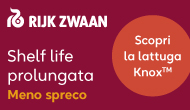Non si placa il dibattito sulle nanoplastiche presenti nell’ortofrutta e rinvenute da un microscopio di ultimissima generazione brevettato dall’Università di Catania, capace di analizzare oggetti infinitesimali, piccoli fino a 100 nanometri e quindi assolutamente invisibili all’occhio nudo. Lo studio apre orizzonti inaspettati sul fronte della sostenibilità in agricoltura oltre a rimettere in discussione, fra l’altro, anche il concetto di riciclabilità, compostabilità e biodegradabilità dei nuovi packaging di origine vegetale.
Affrontiamo il tema nuovamente, questa volta con un genomico, il prof. Luigi Cattivelli, direttore del Centro di Ricerca Genomica e Bio-informatica del CREA, per capire i possibili sviluppi in campo genetico in risposta a questo problema emergente.
– Dott. Cattivelli, come proteggersi, a livello genomico, da questo inquinante. Allo stato dell’arte, ad esempio, è possibile immaginare dei semi ‘smart’, ossia intelligenti, capaci di selezionare gli input ‘negativi’ (inquinanti) che assorbe la pianta, come la plastica?
“Ho letto lo studio dell’Università di Catania e ho fatto un check in letteratura e nelle ricerche genomiche in corso. Che io sappia, al momento, non credo che esista un progetto che riguardi gli smart seeds. Penso però che forse genomicamente siano fattibili. Forse. Bisogna, però, avere a disposizione più dati, ad esempio studi che dimostrino, a livello molecolare, come fanno le nanoplastiche ad entrare nelle piante. Al momento non c’è nulla al riguardo che permetta di sviluppare una pianta in grado di bloccare le nanoplastiche. Lo studio dell’Università di Catania ha aperto un mondo nuovo tutto da scoprire”.
– Riesce ad immaginare un’alternativa agli smart seeds per proteggersi dalle plastiche invisibili?
“Si potrebbe andare ad interferire sui meccanismi che interagiscono con la pianta per fare assorbire le nanoplastiche in base al fatto che siano passivi o attivi”.
– Di che cosa si tratta?
“Un meccanismo passivo, ad esempio, è il flusso dell’acqua che entra dalle radici. Mentre un meccanismo attivo è quello che riesce ad inglobare le nanoplastiche dentro le cellule. Nel primo caso si potrebbe lavorare sull’ambiente che ospita la pianta. Nel secondo sui meccanismi molecolari. Ma ripeto, è un lavoro tutto nuovo e al riguardo c’è pochissima letteratura. Fino a ieri, le nanoplatiche non costituivano un problema in agricoltura”.
– Pensa di poter avviare una ricerca genomica a tal riguardo, tanto più che siamo in una fase di revisione dei regolamenti europei sia sulle new breeding tecnologies che sulle nanoplastiche?
“Se me ne dessero la possibilità, certamente. Naturalmente il discorso cambia per ogni tipo di pianta perché sono tutte diverse a livello molecolare. Ma capiti i meccanismi su alcune varietà su cui si effettuano i test, si potrebbe provare a trasferirli sulle altre specie. L’eliminazione degli inquinanti dalle piante non è un concetto nuovo nella genomica”.
– In che senso?
“Abbiamo scoperto che ci sono piante che hanno la capacità di accumulare metalli pesanti in certi organi come le radici, per cui l’inquinante non arriva alla parte edule. Così accade, ad esempio, nel frumento con l’inquinante cadmio. C’è un gene che impedisce a questo metallo pesante di essere assorbito dal seme”.
– Quindi dei precedenti ci sono?
“Non sulle nanoplastiche. Per andare avanti in questa ricerca, servirebbe un investimento importante in questa direzione e per vedere dei risultati bisognerebbe attendere non meno di quattro-cinque anni. A cui si aggiunge il tempo che ci vorrà per trasferire alle piante che si coltivano. È un processo lungo”.
– La scoperta spinge a rivedere i limiti di legge per le nuove plastiche considerate riciclabili, compostabili o biodegradabli?
“Cambia il paradigma, certo, perché quello che prima ritenevamo non tossico potrebbe esserlo ora. Ma questo, forse, è più un problema nutrizionale. È un mondo tutto da scoprire, potenzialmente molto interessante, ma al momento qui al CREA non lo stiamo prendendo in considerazione. Se dovessero arrivare dei bandi di ricerca, si può valutare prendendo in considerazione una molteplicità di ipotesi”.
– Quali?
“Capire, per esempio, anche come queste particelle vengono assorbite dal suolo. Se il suolo non è inerte, basterebbe aggiungere acqua per farle defluire con gli scarichi. Ma se le sostanze vengono trattenute dal suolo allora ci potrebbero essere degli accumuli che rimarranno per chissà quanti anni e allora non basta più lavarli via. Anche se bisogna considerare che l’inquinamento è frutto di un continuo apporto che, a sua volta, determina comunque un accumulo. Certamente il problema esiste”.
Mariangela Latella